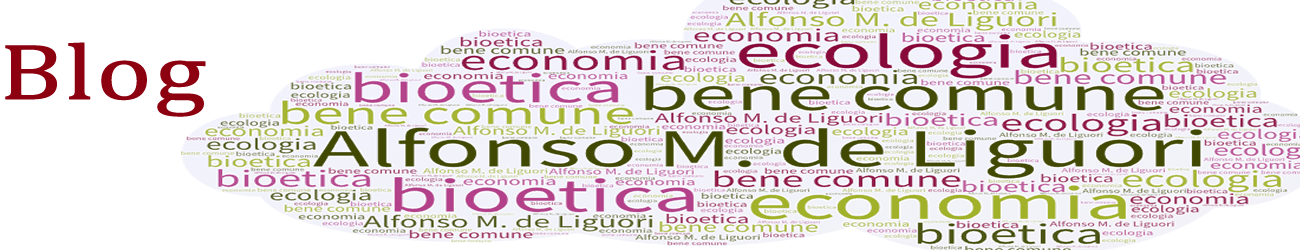Il cronico problema della denatalità in Italia è oggetto recentemente di numerosi studi che individuano molteplici fattori all’origine di un livello di fecondità tra i più bassi d’Europa. La formazione di una famiglia, tuttavia, è favorita da circostanze di pianificazione e stabilità economica e sociale, per questo l’instabilità occupazionale (Brilli – Fanfani – Piazzalunga, 2024), riveste un ruolo rilevante nell’ostacolare le decisioni sulla fecondità, in una situazione decisamente drammatica. Recentemente due ricercatrici, utilizzando i dati sulla “Rilevazione forze lavoro italiane” forniti da Eurostat per il periodo dal 2000 al 2020, hanno esaminato la correlazione tra instabilità lavorativa e probabilità di avere un primo o un ulteriore figlio in Italia (Scherer – Brilli, 2024) e hanno rilevato che l’instabilità occupazionale individuale, come il lavoro temporaneo o la disoccupazione, influenza negativamente la probabilità di avere un figlio sia per gli uomini che per le donne, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e socio-economiche. In particolare, sia la disoccupazione che i contratti a tempo determinato sono associati a probabilità nettamente inferiori di vedere una nascita, rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato. L’instabilità è rilevante soprattutto per la prima nascita e in misura minore per le seconde, mentre la progressione verso ulteriori nascite…
(fonte immagine: www.chiesadimilano.it) Essendo ormai prossimo «il traguardo dei primi venticinque anni del secolo XXI», con la lettera del 11 febbraio 2022 indirizzata al Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Papa Francesco ha invitato tutta la Chiesa a prepararsi alla celebrazione del Giubileo del 2025. Da sempre l’anno giubilare della Chiesa è una speciale occasione di grazia per fare esperienza della misericordia di Dio, in particolare oggi, in una situazione di forte tensione internazionale e dopo il tempo drammatico della pandemia. L’intento di Papa Francesco è quello di «tenere accesa la fiaccola della speranza […] e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante», soprattutto attraverso la capacità per l’umanità «di recuperare il senso di fraternità universale» e di farsi carico del «dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di vivere in maniera degna di esseri umani». In questo senso il Papa ci richiama al fatto che la dimensione spirituale del Giubileo in particolare, che auspica sia «preparato e celebrato con fede intensa, speranza viva e carità operosa», e della vita cristiana in generale, debba necessariamente…
Secondo il Rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), a novembre del 2022 la popolazione mondiale ha superato il livello di otto miliardi di persone, più che raddoppiata negli ultimi 50 anni, con la prospettiva di raggiungere i dieci miliardi entro il 2050. Tale cifra se certifica i progressi dell’umanità nella medicina, nella scienza, nella salute, nell’agricoltura e nell’educazione, allo stesso tempo genera anche alcune preoccupazioni. Tra queste le due principali riguardano: 1) la paura per un mondo sovrappopolato e per il suo impatto sulla crisi climatica, in lotta per risorse sempre più scarse; 2) la preoccupazione per le conseguenze socio-economiche del calo delle nascite associata all’invecchiamento della popolazione, in particolare nei paesi ad alto reddito. L’Europa, ad esempio, vedrà la propria popolazione diminuire del 7% tra il 2030 e il 2050, risultato del calo del tasso di fecondità iniziato negli anni ’70, per cui si troverà con il problema di garantire crescita economica e sostenibilità del sistema di welfare con pochi giovani rispetto ai tanti anziani. Indubbiamente, un legame tra crescita demografica e cambiamenti climatici esiste, perché l’aumento della popolazione e del PIL pro-capite è una delle cause dell’incremento dell’utilizzo di combustibili fossili. Tuttavia focalizzarsi…
Il 27 maggio scorso ricorreva il primo centenario della nascita di don Lorenzo Milani (1923-1967), celebrato con la marcia Vicchio-Barbiana cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, segno inequivocabile dell’importanza e del richiamo che esercita ancora oggi questa «figura incandescente del cattolicesimo italiano, ma anche del pensiero laico e persino dell’indagine scientifica, sociale ed economica» (R. Cesari, 2023). In Esperienze pastorali del 1958, primo e unico libro scritto da don Milani (le altre opere pubblicate sono lettere), emerge la preoccupazione del Sacerdote di annunciare adeguatamente il Vangelo nel contesto sociale in forte cambiamento dell’epoca. Nella Lettera a Elena Pirelli Brambilla del 23.06.1959, egli dirà espressamente: «Sono un parroco di montagna e ho scritto un libro tecnico per i miei confratelli e per nessun altro». I suoi confratelli, infatti, affrontavano la situazione affidandosi all’azione della Grazia che avrebbe portato i fedeli ai sacramenti, per cui l’importante era che la gente andasse in chiesa, poi qualcosa sarebbe successo. Su questo don Milani non era assolutamente d’accordo e riteneva che chiedere a Dio come via ordinaria miracoli strepitosi come quello della «Grazia fulminante quella miracolosa che prende un uomo mal disposto e lo trasforma in apostolo» facendone «la giustificazione quotidiana di…
Nei giorni 21-22 marzo si è svolto a Roma un convegno in occasione dei 150 anni dalla proclamazione a Dottore della Chiesa (23 marzo 1871) di Sant’Alfonso Maria de Liguori (1696-1787) che, nella sua lunga attività, ha elaborato una proposta di vita cristiana in cui i suoi scritti di morale, spiritualità, dogmatica, pastorale, si fondono in una visione originale e unitaria. In particolare, il suo insegnamento morale appare come una pedagogia della vita cristiana volta alla «pratica della carità», proponendosi come la scienza e l’arte di condurre l’anima all’amicizia perfetta con Cristo, mediante la conformità alla volontà di Dio, grazie al «gran mezzo della preghiera» (L. Colin, 1971). La proposta alfonsiana rivolta al ceto popolare del suo tempo, ma non solo, attinge all’originalità stessa dell’annuncio cristiano, presentato con totale fedeltà al Vangelo e radicato nella riflessione patristica e negli scritti ed esperienze di autori e santi tra i quali spiccano Santa Teresa d’Avila e San Francesco di Sales. Tuttavia, raccogliendo gli aspetti tradizionali della spiritualità cristiana, Sant’Alfonso li rielabora e li ripresenta con un’arte che non si trova in nessun altro autore, caratterizzando la sua opera di un’originalità incontestabile. Infatti, non è tanto la creazione o la sintesi nuova di…